Glorioso figlio dell’Appennino: la Valle del Metauro
"La collina marchigiana, volgendosi verso l’interno, è quasi un grande e naturale giardino all’italiana. Non è la collina toscana, né quella umbra. E’ dolce, serena, patetica, lucida, priva di punte. Passando tra i coltivi delle valli ubertose nelle belle giornate si vedono tutte le piante luccicare all’unisono come se le foglie fossero patinate di cera." - Guido Piovene
La Valle del Metauro è uno dei paesaggi più autentici e stratificati delle Marche. Terra modellata dal tempo e dall’acqua, attraversa l’Italia centrale come una dorsale verde sospesa tra Appennino e Adriatico. La valle non è solo una forma geografica, ma una vera e propria narrazione visiva e culturale: dai rilievi dell’alta valle, severi e solitari, si scende verso colline più morbide, punteggiate di oliveti, vigneti e borghi in pietra che ancora conservano il respiro delle epoche passate. Qui la natura si intreccia alla memoria, e ogni elemento — un muretto a secco, una casa colonica, una chiesa romanica — parla di una civiltà contadina profondamente radicata e di una storia millenaria che ha lasciato tracce visibili e vive. La valle, teatro della storica battaglia del 207 a.C. tra Romani e Cartaginesi, è anche luogo di passaggio, di scambi, di contaminazioni tra popoli, che ancora oggi si riflettono nel dialetto, nella cucina e nei riti locali.
Nel cuore di questo paesaggio scorre il fiume Metauro, figlio dell’Appennino e testimone silenzioso di secoli. Torquato Tasso, ospite a Urbino nel 1578, gli dedicò una delle sue più sentite liriche, la Canzone al Metauro, definendolo “figlio picciolo sì, ma glorioso”. Per Tasso, il fiume non era solo acqua, ma metafora dell’esistenza, specchio dell’anima inquieta del poeta. Così, il Metauro diventa nella letteratura un interlocutore, un luogo dell’interiorità, un confidente discreto capace di accogliere gioie e tormenti.
«O del grand’Apennino
figlio picciolo sì ma glorioso,
e di nome più chiaro assai che d’onde;
fugace peregrino
a queste tue cortesi amiche sponde
per sicurezza vengo e per riposo.
L'alta Quercia che tu bagni e feconde
con dolcissimi umori, ond’ella spiega
i rami sì ch’i monti e i mari ingombra,
mi ricopra con l’ombra.
L’ombra sacra, ospital, ch’altrui non niega
al suo fresco gentil riposo e sede,
entro al piú denso mi raccoglia e chiuda,
sì ch’io celato sia da quella cruda
e cieca dèa, ch’è cieca e pur mi vede,
ben ch’io da lei m’appiatti in monte o ‘n valle
e per solingo calle
notturno io mova e sconosciuto il piede;
e mi saetta sì che ne’ miei mali
mostra tanti occhi aver quanti ella ha strali.»
— Torquato Tasso, da "Canzone al Metauro"
Il Metauro attraversa comunità che ancora oggi conservano il senso del vivere lento, dove le tradizioni contadine si fondono con una rinnovata sensibilità ecologica e culturale. Isola del Piano, Fossombrone, Urbania, e tanti altri centri minori sono come stazioni di un racconto che si muove lungo le anse del fiume: qui il territorio parla, attraverso i muri delle case, i nomi dei campi, le festività legate al ritmo delle stagioni. È un paesaggio che ispira non solo poeti e pittori, ma anche chi cerca un’esperienza autentica del vivere.
Torquato Tasso coglie il valore di questo fiume non tanto per la sua imponenza, ma per la sua dignità storica e simbolica, perché il Metauro, come la valle che lo accoglie, è portatore di un’identità forte, silenziosa, consapevole. È un luogo che non ha bisogno di gridare per farsi ricordare.







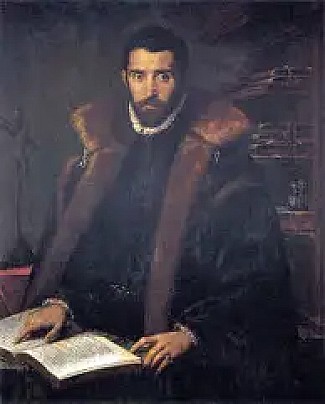






-thumb.jpg)


-thumb.jpg)






